Corruzione in Grecia e in Italia: una deriva sistemica tra cultura politica e crisi dello Stato di diritto
Di Evangelos Alexandris Andruzzos
Non sorprende che Grecia e Italia condividano da anni posizioni basse negli indici internazionali sulla percezione della corruzione. Non si tratta solo di deviazioni episodiche, ma di una degenerazione sistemica che affonda le radici in una cultura politica premoderna, dove il principio dell’interesse generale è stato storicamente subordinato a logiche clientelari, corporative e di sopravvivenza partitica.
La recente relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto in Grecia non lascia dubbi: ritardi nella giustizia che sfiorano la negazione del diritto, una fiducia popolare in caduta libera nei confronti dell’indipendenza giudiziaria (dal 55% del 2021 al 38% nel 2025), un’opacità cronica nei meccanismi di nomina delle autorità indipendenti, e un sistema legislativo ipertrofico che genera incertezza e inibisce gli investimenti.
In Italia, sebbene alcune riforme siano state tentate, i problemi strutturali non divergono radicalmente: la lentezza dei procedimenti giudiziari, l’eccessiva politicizzazione di alcune istituzioni, e un uso spesso strumentale del diritto da parte del potere politico, contribuiscono a un sentimento diffuso di sfiducia, apatia e rassegnazione.
Ciò che accomuna le due società non è solo la statistica, ma una grammatica politica comune: quella dell’ambiguità tra legalità formale e illegalità funzionale. L’illegalità non è più solo devianza, ma spesso risorsa, strumento di mediazione, canale di mobilità sociale o mezzo di sopravvivenza economica. In tal senso, la corruzione non appare più come una “patologia”, bensì come un “ecosistema” in equilibrio precario.
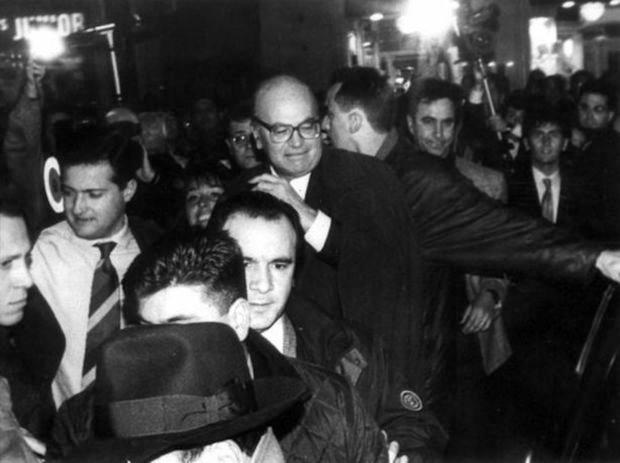
Uno degli aspetti più inquietanti è la trasformazione del rapporto tra cittadino e Stato. Come sottolineato dal prof. Delli in riferimento alla Grecia, l’uomo politico è passato da “patrono” a “cliente”, in un capovolgimento che svuota le istituzioni della loro funzione regolatrice e le trasforma in distributrici di favori, premi e impunità. Le pubbliche amministrazioni diventano così terreno di conquista, e non strumenti di servizio.
Anche in Italia, soprattutto a livello locale, il fenomeno del cosiddetto “consociativismo” ha favorito per decenni la cooptazione piuttosto che la meritocrazia. In entrambi i Paesi, la legittimazione politica non si fonda più sulla progettualità o sul servizio alla collettività, ma sulla capacità di garantire micro-privilegi, deroghe, eccezioni.
A livello macrostrutturale, siamo di fronte a una crisi dello Stato moderno come portatore di legalità impersonale. La coesione sociale, minacciata dalla disuguaglianza crescente, dall’insicurezza economica e dall’esaurimento delle grandi narrazioni ideologiche del Novecento, lascia spazio a una “neotribalizzazione” della politica: corporazioni, lobbies, clientele, reti informali.
L’Europa, nel tentativo di imporre standard di legalità, si trova davanti a un dilemma: come riformare sistemi in cui il diritto è spesso vissuto come imposizione esterna, e non come patto condiviso? Come creare anticorpi contro la corruzione, se la stessa cultura civica risulta debole o frammentata?
La risposta, a mio avviso, non può essere solo istituzionale o normativa. Occorre un processo educativo di lungo periodo, una “socioterapia collettiva” capace di risignificare il senso del bene comune, di ricostruire un’etica pubblica condivisa, e di valorizzare le esperienze virtuose, spesso marginalizzate, che pure esistono in entrambi i Paesi.
Serve un nuovo umanesimo istituzionale che rimetta al centro la dignità del cittadino come persona pensante e partecipe, e non come suddito da premiare o punire. Solo così potremo uscire dal circolo vizioso della sfiducia e cominciare a costruire, finalmente, uno Stato di diritto non solo formale, ma anche reale.

![]()
Great article, thanks for sharing such valuable insights! 🙌 I really appreciate the way you explained the topic so clearly and made it easy to understand. It’s rare to find content that is both informative and practical like this. By the way, I recently came across a helpful platform called profis-vor-ort.de — it connects people quickly with local experts and services in Germany. I think it could be a great resource for anyone interested in finding trustworthy professionals nearby. Keep up the great work, I’ll definitely be following your future posts!
Fantastic read! 👏 I really appreciate how clearly you explained the topic—your writing not only shows expertise but also makes the subject approachable for a wide audience. It’s rare to come across content that feels both insightful and practical at the same time. At explodingbrands.de we run a growing directory site in Germany that features businesses from many different categories. That’s why I truly value articles like yours, because they highlight how knowledge and visibility can create stronger connections between people, services, and opportunities.Keep up the great work—I’ll definitely be checking back for more of your insights! 🚀
Mercati e poteri politici, la democrazia in discussione
Di Evangelos Alexandris Andreuccio
Economia degli Oligopoli e Nuove Disuguaglianze: una lettura sociologica
Il fenomeno della concentrazione del potere economico nelle mani di pochi non è soltanto una questione tecnica di funzionamento dei mercati, ma un problema sociale e culturale che mette in crisi le stesse basi della convivenza democratica. Ci troviamo di fronte a un paradosso storico: ciò che era nato come promessa di libertà – il mercato aperto, competitivo e plurale – si trasforma progressivamente in meccanismo di esclusione, di chiusura e di dominio oligopolistico.
Dal punto di vista sociologico, questa dinamica rappresenta un processo evolutivo in cui il teorico diventa pratico, e il pratico travolgente.
Karl Polanyi, nella sua grande opera La Grande Trasformazione, aveva già segnalato come la logica autoregolata del mercato portasse a forme di disintegrazione sociale, a una “mercificazione” della vita che mina il tessuto stesso delle società. Oggi, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno reso questo processo ancora più radicale: non è solo l’economia a concentrare il potere, ma la conoscenza, la comunicazione e persino l’immaginario collettivo.
Max Weber parlava del “disincanto del mondo” e della crescente razionalizzazione burocratica: oggi potremmo tradurlo in “tecnocratizzazione globale”. Le grandi piattaforme tecnologiche, i colossi finanziari, le catene alimentari ed energetiche non sono più semplici attori economici: diventano istituzioni totali (per riprendere Erving Goffman), capaci di orientare il comportamento, il consumo, le relazioni, perfino la percezione della realtà.
Pierre Bourdieu ci offre un’altra chiave di lettura: l’accumulazione non riguarda solo il capitale economico, ma anche quello culturale e simbolico. Quando poche multinazionali detengono la capacità di diffondere narrazioni, di definire il linguaggio politico e mediatico, assistiamo a un fenomeno di violenza simbolica che rafforza l’ineguaglianza e rende opaca la possibilità di un reale cambiamento.
I dati empirici parlano chiaro:
Quattro aziende controllano la pubblicità digitale globale.
Cinque gestiscono le infrastrutture del cloud, cioè la base stessa della nostra comunicazione e dei nostri archivi di conoscenza.
Tre colossi bancari dominano oltre metà dei depositi negli Stati Uniti.
Questa oligarchia economico-tecnologica non produce solo squilibri materiali, ma costruisce una nuova forma di assolutismo dispotico: un potere che non ha volto politico nel senso tradizionale, ma che esercita un’influenza pervasiva e difficilmente contrastabile. Come sottolinea Zygmunt Bauman, la modernità liquida dissolve i vecchi punti di riferimento, ma allo stesso tempo rende l’individuo più vulnerabile a nuove forme di dominio, invisibili ma pervasive.
Il problema, dunque, non è più se il liberalismo o il mercato abbiano “fallito”, ma se la società sia ancora in grado di immaginare un nuovo equilibrio tra libertà individuale, giustizia sociale e limiti istituzionali al potere. La sfida è evitare che la promessa di libertà si rovesci nel suo contrario: una forma di neo-feudalesimo tecnologico, dove i sudditi non sono più vincolati dalla terra, ma dai dati, dagli algoritmi e dalle reti di dipendenza economica e sociale.
In questo senso, la questione è eminentemente sociologica: riguarda la capacità collettiva di resistere e reinventare spazi di pluralismo, di innovazione diffusa, di autonomia. Se, come diceva Habermas, la sfera pubblica è il cuore della democrazia, oggi essa rischia di essere privatizzata, catturata da pochi nodi di potere globale. La posta in gioco non è soltanto la giustizia distributiva, ma la stessa sopravvivenza della libertà come pratica sociale condivisa.
L’analisi diventa ancora più incisiva se si guarda al ruolo di paesi come Italia e Grecia nella divisione internazionale del lavoro. Entrambe, seppure con caratteristiche diverse, si trovano schiacciate tra due forze contrapposte: da un lato l’eredità di uno Stato sociale europeo, costruito nel dopoguerra e fondato su meccanismi di redistribuzione, di welfare e di diritti collettivi; dall’altro la pressione incessante dei grandi centri finanziari globali, che attraverso la leva del debito, dei mercati e delle infrastrutture tecnologiche impongono regole e vincoli spesso incompatibili con la sostenibilità sociale.
L’Italia, con la sua base manifatturiera frammentata e legata a distretti territoriali, e la Grecia, segnata dal peso del turismo e delle importazioni energetiche, rappresentano due esempi emblematici di come la globalizzazione abbia accentuato la dipendenza da logiche esterne: catene globali del valore, piattaforme digitali sovranazionali, mercati finanziari transnazionali. Entrambe hanno vissuto, in forme diverse, la perdita di sovranità economica nel decennio delle crisi: il commissariamento economico della Grecia durante la crisi del debito e i vincoli strutturali imposti all’Italia nel quadro dell’austerità europea sono testimonianze concrete di come la capacità di governo nazionale venga subordinata a decisioni prese altrove.
In questa dinamica, lo Stato sociale europeo – fondato sull’idea di equità e redistribuzione – viene progressivamente eroso. Sanità, istruzione, pensioni e politiche attive del lavoro sono costrette a ricalibrarsi secondo la logica del contenimento della spesa e della competitività globale, più che su quella dei diritti universali. Italia e Grecia, collocate nella periferia produttiva dell’Europa, diventano così laboratori di sperimentazione delle nuove disuguaglianze: precarietà, fuga di cervelli, impoverimento del ceto medio, emigrazione giovanile, trasformazione dei servizi pubblici in beni di mercato.
Il paradosso è evidente: le conquiste sociali che avevano reso l’Europa un modello di equilibrio tra economia e coesione sociale vengono ora progressivamente smantellate sotto la pressione di un oligopolio economico-finanziario che non solo concentra la ricchezza, ma svuota le democrazie nazionali della loro capacità decisionale. Italia e Grecia diventano così esempi paradigmatici di una sfida che riguarda l’intero continente: come difendere la giustizia sociale e la democrazia di fronte a un mercato globale che, privo di contrappesi, tende inevitabilmente al dominio oligopolistico.